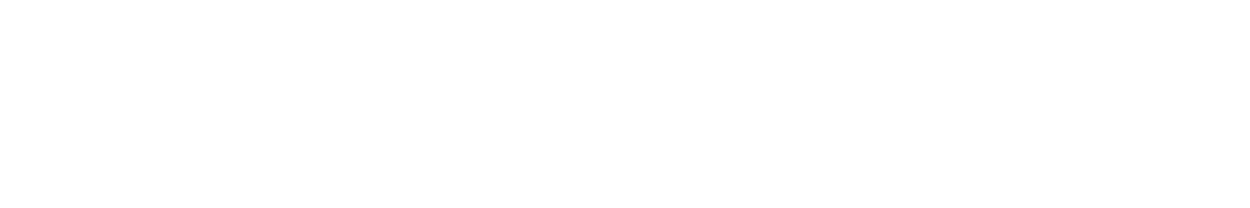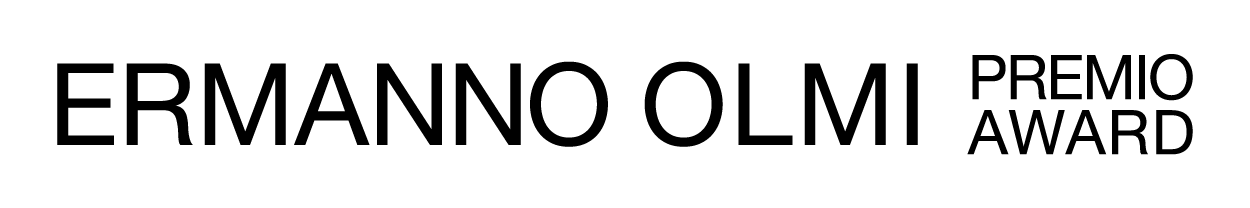Il suo cinema ha sempre dimensioni sincere, apparentemente ingenue ma estremamente vere come i buoni sentimenti e le virtù nascoste. I suoi ritratti di situazioni e personaggi cosi comuni, mediocri e drammaticamente noti nel vivere quotidiano, riescono tuttavia a dare un contributo non indifferente alla comprensione delle contraddizioni della attuale società italiana”. Le citazioni servono, credo, a stabili- re la continuità dell’opera di Olmi e a ricordare che L’albero degli zoccoli non germina di colpo in una stagione sola, ma cresce a poco a poco, pazientemente, nello spazio di molti anni, come natura comanda.
 Cannes, primavera 1978. L’albero degli zoccoli, di Ermanno Olmi, ottiene la Palma d’Oro, attribuita all’unanimità da una giuria formata da Alan J. Pakula (presidente), Liv Ullman, Franco Brusati, François Chalais, Michel Ciment, Claude Goretta, Andrei M. Kontchalovski, Harry Saltzman, Georges Wakhevitch. “La giuria – si sottolinea – non ha accettato alcuna imposizione, giudicando realmente sulla base della qualità delle pellicole senza subire condizionamenti di natura opportunistica”. Il film di Olmi vince anche il “Premio Ecumenico” attribuito congiuntamente dalle organizzazioni OCIC (Ufficio cattolico internazionale del cinema) e INTERFILM (Centro internazionale evangelico del film).
Cannes, primavera 1978. L’albero degli zoccoli, di Ermanno Olmi, ottiene la Palma d’Oro, attribuita all’unanimità da una giuria formata da Alan J. Pakula (presidente), Liv Ullman, Franco Brusati, François Chalais, Michel Ciment, Claude Goretta, Andrei M. Kontchalovski, Harry Saltzman, Georges Wakhevitch. “La giuria – si sottolinea – non ha accettato alcuna imposizione, giudicando realmente sulla base della qualità delle pellicole senza subire condizionamenti di natura opportunistica”. Il film di Olmi vince anche il “Premio Ecumenico” attribuito congiuntamente dalle organizzazioni OCIC (Ufficio cattolico internazionale del cinema) e INTERFILM (Centro internazionale evangelico del film).
I giudizi critici fanno a gara ad esaltare la pellicola. “Dono raro” – scrive il “Corriere della Sera” – “grande lezione d’arte”, “il film durerà più della nostra generazione”. “Film che resterà” – gli fa eco “Il Giorno” – definendolo un “solenne ‘ poema” e il “frutto di una splendida maturità”.
“Capolavoro” è un termine che si ritrova più volte (“L’Europeo”, “La Repubblica”, per es.). ”Testimonianza sincera e felicemente ispirata”, dice “L’Unità”. “Uno dei canti più poetici che ci abbia proposto il cinema italiano, un’egloga di Virgilio ricreata con le tecniche della più moderna delle arti”, pubblica “Il Tempo”. A Virgilio si rifà anche “France-Soir” (”bello quanto un .testo di Virgilio”) mentre “L’Humanité” afferma che che il film “ha una purezza di cristallo” Poi, più avanti, qualcuno insinuerà delle riserve, ma intanto l’accoglienza è trionfale. Presentato successivamente a Locarno, a Montreal, a Firenze (Premi David di Donatello), la fatica di Olmi riscuote apprezzamenti grandiosi. La RAI – produttrice insieme con l’ltalnoleggio – annuncia con orgoglio che il film è stato venduto in una ottantina di paesi, compresi URSS, Giappone, Vietnam (ma l’elenco si allunga man mano). Insomma è scoppiato il “caso” Olmi. La cosa fa più impressione perché il regista bergamasco è sempre stato schivo, si ritiene sciolto da ogni giuramento e lavora in silenzio; tanto che lo si emargina, il silenzio glielo si crea attorno. È poi una sorpresa davvero cosi grossa, l’affermazione (o addirittura la “presenza”) di Olmi? “Cineforum” (il discorso ci serve solo per collegare le precedenti fatiche di questo regista a L’albero degli zoccoli) si è sempre occupato di lui, ed in modo piuttosto attento. Ampie “schede” sono state dedicate a Il tempo si è fermato (1959, il lungometraggio dell’esordio dopo la produzione documentaristica per I’Edisonvolta), a Il posto (1961), a I fidanzati (1963). Ma fin qui è facile occuparsi di Olmi in maniera esauriente, lo fanno tutti; il “merito” vien dopo, con i film (a partire da E venne un uomo, 1965) che scandiscono momenti di crisi o comunque una ricerca non sempre sicura di questo regista, e vedono la critica farsi distratta o sufficiente.
Un certo giorno (1969), per esempio, che con il successivo La circostanza (1973) segna l’avvicinamento di Olmi, dopo quella proletaria, ad una realtà borghese con esiti discutibili nel senso etimologico della parola, cioè gonfi di problematiche complesse, anche se non tutte risolte. Darko Bratina, sulla nostra rivista, afferma a proposito di Un certo giorno che “nonostante il discutibile esito di qualche anno fa con E venne un uomo, Ermanno Olmi resta una delle personalità più singolari del giovane cinema italiano, soprattutto direi per la sua semplicità, che di questi tempi è genuinamente anticonformista. Il suo cinema ha sempre dimensioni sincere, apparentemente ingenue ma estremamente vere come i buoni sentimenti e le virtù nascoste. I suoi ritratti di situazioni e personaggi cosi comuni, mediocri e drammaticamente noti nel vivere quotidiano, riescono tuttavia a dare un contributo non indifferente alla comprensione delle contraddizioni della attuale società italiana”. Le citazioni servono, credo, a stabilire la continuità dell’opera di Olmi e a ricordare che L’albero degli zoccoli non germina di colpo in una stagione sola, ma cresce a poco a poco, pazientemente, nello spazio di molti anni, come natura comanda.
Sandra Scandolara, per I recuperanti (1969) – che inaugura la collaborazione tra Olmi e la RAI-TV – chiarisce gli equivoci che si ripetono attorno all’opera di questo regista. “E da Il posto che Olmi viene costantemente considerato il cantore delle piccole cose e dei buoni sentimenti, una specie di De Amicis della metropoli industriale, un bonario narratore di piccoli scrivani dell’Edison, un glorificatore dei corsi profes-sionali. In quest’equivoco siamo caduti un po’ tutti, specie in un periodo in cui andavano molto più di moda le ricchissime incomunicabilità antonioniane…” . E invece i personaggi di Olmi “presentano l’umanità e la grandezza morale tipica della povera gente”; il suo buon senso “è tutto meno che qualunquismo, la sua passione per le piccole cose non è riduzione all’affettività”; per Olmi l’attenzione alle piccole cose non costituisce un minimizzarle ma un renderle più grandi, significa creare proprio nella piccolezza umana ciò che rende grande l’uomo”.
Motivi, avverte Scandolara, “dinanzi ai quali si drizzano subito le orecchie e ci si pone in sospetto perché rappresentano l’ultima barricata, quella uterina, della reazione) perché i loro valori, mitizzati, assolutizzati, vengono sbandierati allo scopo di contrabbandare la difesa dello “status quo”” .
l recuperanti – cosi conclude l’ampia scheda destinata al film – costituisce “una focalizzazione sull’umano e rappresenta un recupero della spontaneità, della comunicazione individuale: ed è di ciò che oggi abbiamo bisogno, quando si considerino la solitudine e la non-comunicazione un frutto del capitalismo. L’attenzione di Olmi alle minuzia di cui è fatta la nostra vita è la ricerca di un territorio ancora vergine, ancora libero; è un atto di fede e d’amore e come tale rivoluzionario”.
Il punto più flebile di questo periodo si identifica con Durante l’estate (1971 ), operina sorridente ma debole e soprattutto vaporosa, non adatta alle corde di Olmi (il soggetto e la sceneggiatura erano di Fortunato Pasqualino, e questo spiega molte cose). È ancora Scandolara che vi dedica la sua attenzione su “Cineforum”, salvando le piccole figure da cui salta fuori “l’amore per l’uomo, la pietà per la sua solitudine, per le piccole manie che alleviano la fatica di vivere”, ma formulando con chiarezza il sostanziale giudizio negativo: “Tutto resta rarefatto e subdolamente “mistico”, teso a cercare significati reconditi nell’inespresso e nei simboli”.
L’impatto più severo con l’operato di Olmi si ha nella scheda in cui Roberto Escobar analizza La circostanza (1973), dove vengono messe in discussione alcune incrostazioni che si so- no andate formando attorno alla figura e all’operato del regista bergamasco. Anche se alcuni possono ritenere eccessivamente drastiche le valutazioni negative di Escobar, si tratta nondimeno di un tentativo molto serio di andare a fondo nei giudizi su Olmi e di respingere la facile tentazione (di cui sono in molti ad essere vittime) di inscrivere questo regista in schemi di comodo e di continuare a giudicarlo, in bene e in male, secondo tali schemi precostituiti. Il nostro tentativo qui, trattando di L’albero degli zoccoli, è proprio quello di ignorare anatemi e trionfalismi, definizioni facili e incasellamenti rituali, e cercare di penetrare il senso del film in sè.
La circostanza è il film che precede immediatamente L’albero degli zoccoli, anche se fra uno e l’altro stanno cinque anni. In mezzo, una regia televisiva (Alcide De Gasperi), e un lavoro paziente di preparazione e di lavorazione dell’ultima pellicola. A proposito di televisione, va rilevato l’apprezzamento tributato alle precedenti fatiche televisive di Olmi, soprattutto alle puntate a lui affidate di una inchiesta sui giovani (“La cotta“, “Piccoli discorsi“, “Le delusioni“, del 1966) e di alcuni “servizi storici” sulla “Nascita della Repubblica” (“La Costituzione” e “Le radici della libertà“).
STRUTTURA DI L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI
(I fatti narrati avvengono tra l’autunno del 1897 e la primavera del 1898).
– Nella sacristia della chiesa parrocchiale, dopo i “Vespri” di una domenica, il parroco spinge Batistì e sua moglie a mandare il figlio Minek (Menico, Domenico) a scuola (“L ‘è ü s:cet de fà stödià” = È un ragazzo da far studiare).
– I due coniugi tornano alla loro cascina, mentre appaiono essenziali titoli di testa. Sul “totale” della cascina, didascalia: “Così doveva apparire la cascina lombarda alla fine del secolo scorso. Ci vivevano quattro, cinque famiglie di contadini… La casa, la stalla, la terra, gli alberi, parte del bestiame e degli attrezzi appartenevano al padrone e a lui si dovevano due
parti del raccolto”.
– Momenti di vita contadina: la semina, l’aratura, la nascita di un cavallino, la raccolta del granoturco, la sistemazione del fieno nella stalla, l’uccisione dell’oca, la spannocchiatura.
– l contadini portano il granoturco alla pesatura, nel cortile del padrone, che delega al controllo il suo fattore. Il vecchio Finard mette nel cassetto del carro delle pietre per fare più peso.
– Giopa, lo scemo del paese, visita le famiglie della cascina biascicando preghiere e rimediando sempre qualcosa da mangiare.
– La vedova Runk, rimasta sola con sei bambini, fa la lavandaia. Pepino, il figlio maggiore, bada alla stalla insieme al nonno Anselmo; le due bambine più grandi vanno avanti e indietro dal paese al fosso con carriolate di panni da lavare.
– Finisce la giornata lavorativa al filatoio della seta. Maddalena, operaia figlia dei Brena, torna alla cascina, seguita da un giovanotto, Stefano, che la corteggia.
– Il mattino, Minek va a scuola, mentre nonno Anselmo raccoglie concime per seminare i pomodori e Pepino va al mulino col grano. Il mugnaio gli propone di andare a lavorar da lui.
– Nella stalla, di sera, le famiglie riunite. Il Batistì racconta storie e filastrocche. Stefano con alcuni amici arriva per ascoltare e soprattutto per guardare Maddalena.
– Stefano, nel tornare a casa, si attarda nell’aia della cascina del padrone, dove il figlio di quest’ultimo suona il piano per degli ospiti. Cade la prima neve.
– Nonno Anselmo, invano rimproverato dalla vedova Runk, si alza per mettere il letame sul terreno dove poi seminerà i pomodori.
– Un mattino che piove, in cascina si ammazza il maiale, tra l’eccitazione generale. Arriva il parroco, che cerca la vedova Runk. La raggiunge al fosso, dove la donna sta lavando i panni, e le propone di far ritirare i due figli più piccoli in un istituto di suore, cosi avrà meno bocche da sfamare.
– A casa, la sera, la vedova chiede il parere di Pepino, il figlio maggiore che torna dal suo lavoro al mulino. Pepino preferisce che si stia tutti insieme: lui si darà più da fare, una sorella è vicina ai dodici anni e potrà andare in filanda, uno dei piccoli potrà aiutare il nonno nella stalla.
“l nost’ fradei mi té’n cà con noter”, decide (“I nostri fratelli li teniamo in casa con noi”).
– La mucca della vedova Runk è malata, si chiama il veterinario il quale si limita a constatare la gravità della situazione. La donna non si rassegna: si reca ad una cappella dove, accanto, scorre un fosso, riempie di quell’acqua un fiasco, prega Dio di farle la grazia di far guarire la mucca, torna alla stalla dove fa bere quell’acqua alla bestia. Il giorno dopo la mucca appare guarita.
– Una sera che torna dal lavoro, Maddalena è attesa da Stefano, che le chiede invano ” ü basi” (un bacio). Il Finard, in cascina, ha un ennesimo violento litigio col figlio, reo di non curare con diligenza i suoi interessi.
– Con l’arrivo della primavera, arriva sull’aia il Friki, il merciaiolo ambulante che vende alle donne stoffe e nastri. La Brena, madre di Maddalena, compera una pezza di stoffa per la figlia che deve sposarsi.
– È la sagra del paese. In chiesa il parroco tiene la predica. In piazza funzionano giostre e fanno affari saltimbanchi e venditori ambulanti. All’osteria si beve e si balla. Il Brena torna a casa ubriaco. In paese un oratore parla ai contadini di progresso sociale e di umani diritti, e intanto il Finard, che per curiosità si è unito agli ascoltatori, trova per terra un marengo d’oro. Se ne appropria sogghignando e, a casa, lo nasconde sotto lo zoccolo di un cavallo.
– Un mattino chiamano il Batistì, nei campi, perché sua moglie sta per partorire. È un altro maschio, ma anche un altro pensiero in più, un’altra bocca da sfamare.
– All’uscita dalla scuola, quel giorno, a Minek si spacca uno zoccolo. Torna a casa come può, arriva in ritardo, conosce il nuovo fratellino. Appena buio il Batistì esce di casa e taglia furtivamente un piccolo pioppo dal filare lungo il canale. Di notte ricava dal tronco due zoccoli nuovi.
– Si annuncia la primavera. Nonno Anselmo trapianta le piantine di pomodoro all’aperto, accompagnato da una nipotina. Mentre un temporale si scatena, nella stalla Batistì racconta una storia da brivido. Di giorno, mentre gli adulti lavorano i campi e le donne raccolgono la cicoria, nonno Anselmo insegna ai bambini la filastrocca – accompagnata ritualmente da rumori di pentole e coperchi – per cacciar via l’inverno (“Pica fort, piea pià, che l’inverno ‘n taca vià”).
– Un giorno, mentre attacca il cavallo al carro, il Finard controlla il suo marengo sotto lo zoccolo e si accorge che è sparito. Pazzo di rabbia, si sfoga contro il cavallo. È costretto a mettersi a letto, dov’è visitato dalla fattucchiera (la “donna del segno”).
– Il matrimonio di Maddalena e Stefano. l due sposi vanno in chiesa di primo mattino perché subito dopo la cerimonia devono partire per Milano, a visitare la sorella della madre di Maddalena, superiora del convento di suore di Santa Caterina della Ruota. Il viaggio fino a Milano viene compiuto su un barcone che scorre sul Naviglio; un viaggio lungo, punteggiato dalla pausa di mezzogiorno, e, verso sera, dall’allarme causato da una colonna di fumo avvistata nella campagna. Forse si tratta, dice un prete, dei segni di una battaglia di soldati contro i dimostranti, come già ce n’è state. Subito dopo l’arrivo in città, i due sposi incrociano un corteo di dimostranti prigionieri e sentono vicini i fragori di uno scontro. Al convento, suor Maria li rifocilla e li ospita. Il mattino dopo li convince a tornare al paese con un piccolo orfanello di due anni.
– Il padrone del fondo, durante una perlustrazione, si accorge del pioppo tagliato. Mentre il fattore è mandato ad indagare, nonno Anselmo raccoglie i suoi pomodori in anticipo sugli altri e va a venderli in paese con la nipotina. Al ritorno apprende che il Batistì, scoperto come responsabile del taglio dell’albero, è stato cacciato dal padrone. Poco dopo arriva il fattore a portarsi via mucca e vitello, e la sera stessa il Batistì e la sua famiglia, caricate le masserizie sul carretto, abbandonano la cascina.
NOTIZIE SUL FILM
Prima di L’albero degli zoccoli c’è, come detto, La circostanza, del 1973.
L’ultimo film di Olmi ha richiesto al suo autore diversi anni di lavoro, svolto in silenzio, fuori dal “giro” del cinema commerciale.
Produttori del film sono la RAI-TV e l’ltalnoleggio, il costo è di 320/350 milioni. La “troupe” è ridotta, alla cinepresa è lo stesso Olmi, che usa una pellicola speciale in modo da utilizzare quasi esclusivamente la luce naturale (quella del sole per gli esterni, quella delle candele e delle lampade a petrolio per gli interni). Il montaggio è effettuato personalmente da Olmi in modo artigianale, utilizzando una moviola impiantata nello scantinato della sua casa, ad Asiago. Il montaggio richiede molti mesi di lavoro.
Le riprese avvengono (autunno 1976/ primavera 1977) nella Bassa bergamasca, una zona agricola fra i paesi di Martinengo e di Palosco, con puntate nelle vicine località di Cividate, Mornico, Cortenuova e Treviglio.
Gli interpreti – che recitano in dialetto e in presa diretta – sono tutti non-attori, reclutati nella zona. Il “Batistì” è un contadino di una frazione rurale di Treviglio, sua “moglie” una casalinga di Brignano Gera d’Adda, “Maddalena” una ragazza che lavora in fabbrica e abita ad Urgnano, “Stefano” un falegname di Castel Cerreto, “nonno Anselmo” un agricoltore pensionato di Treviglio, il “curato” un disegnatore in pensione ancora di Treviglio, e cosi via. Pur lavorando su una sceneggiatura minuziosa, Olmi lascia spazio, quando occorre, all’improvvisazione. “Non si poteva certo rispettare ogni frase e ogni parola, la spontaneità sarebbe andata a farsi benedire – ha dichiarato – lo suggerivo una frase, spiegavo il concetto; poi loro, i contadini-attori, la ripetevano a modo loro, magari infiorandola, magari usando modi di dire a loro familiari, cosa che a me andava benissimo perché più spontanea, perché dava più forza e naturalezza al discorso”.
Del film esiste, oltre all’edizione originale parlata in dialetto bergamasco, una versione identica ma con sobrie didascalie in italiano e una doppiata in italiano bergamaschizzato dagli stessi interpreti, curata dalla ADC (cooperativa Attori Doppiatori Cinematografici), diretta da Aldo Danieli. Olmi non avrebbe voluto quest’ultima versione: “La parlata dialettale del film non è un mio puntiglio di ordine estetico – polemizza con l’ltalnoleggio – ma un dato essenziale del racconto. Il dialetto era la sola lingua che i contadini conoscevano: non sapevano parlare quella del padrone e anche per questo erano degli emarginati… col doppiaggio tutto questo andrà perduto e in più si sconvolgeranno i connotati stessi dei personaggi perché verranno privati del suono naturale della loro lingua”.
DICHIARAZIONI DI OLMI
Cosa intende essere L’albero degli zoccoli nelle intenzioni del suo autore? Estrapoliamo da sue dichiarazioni e interviste varie alcune definizioni, che ci serviranno poi per analizzare i risultati.
“L’albero degli zoccoli è nato in modo abbastanza curioso. L’ltalnoleggio mi aveva chiesto di fare un film per ragazzi. La cosa mi interessava oltretutto da vicino, a livello familiare, visto che ho tre figlioli. Mi sono chiesto che cosa potevo raccontare a dei ragazzi e ho concluso che poteva interessare loro – ma naturalmente non soltanto a loro – questo tipo di ricordi ai quali, anche se non ne sono stati direttamente partecipi, tuttavia non sono estranei”.
Il progetto risaliva alla fine degli Anni Cinquanta, quando Olmi aveva cominciato a prender nota dei racconti di sua nona Elisabetta, di nonno Anselmo e della gente conosciuta in una cascina presso Treviglio, quand’era ragazzo. “Mia nonna era una gran narratrice, sapeva attrarre la gente, incantarla con le sue storie. Nel mio film ci sono tutti quei personaggi, molti erano miei lontani parenti, una sorta di cronaca familiare. L’albero degli zoccoli ho cominciato a scriverlo alla scomparsa della nonna, circa vent’anni fa, per fissare le nostre conversazioni sulla carta. Era il mio primo soggetto per il cinema”.
“Il film rappresenta per me un ritorno alle origini, un guardarmi dentro.
I miei primi tre film, Il tempo si è fermato, Il posto, I fidanzati, si collocavano nel mondo operaio, scaturito però dall’ultima generazione contadina. Poi mi sono rivolto al mondo borghese (Un certo giorno, La circostanza) cercando di rappresentare quel ruolo vorrei dire fallimentare che ha finito per assumere troppo spesso il borghese nella borghesia d’oggi. Con i miei stessi disagi. Anch’io mi sento un borghese fallito, fuori posto. Fino a diciotto anni sono vissuto in una zona popolare di un quartiere milanese, a San Siro, in una casa operaia. Quando sono arrivato al cinema, mi sono ritrovato, sempre a San Siro, ma al di là di uno spartiacque che sono i binari di un tram: di qua le case operaie, di là quelle borghesi. Però, pur vivendo in quelle case, sentivo di aver soltanto attraversato i binari di un tram, perché la mia realtà era rimasta dall’altra parte. Adesso l’ho ritrovata. Pur con tutte le ambiguità e i privilegi della condizione borghese sono andato a vivere ad Asiago, dove ho potuto riallacciare rapporti con una comunità che conserva in qualche modo l’unità di cui aveva dato prova il mondo contadino. Questo mi ha permesso di confrontarmi con il mio passato e di trovare di nuovo delle risposte nel presente. Le uniche possibili, quelle della terra. Che ho tentato di sug-gerire anche nell’Albero degli zoccoli“.
“Non possiamo non confrontarci col passato. È l’unico termine di paragone che abbiamo per costruire il futuro. Oggi il progresso ha fatto scomparire tutto un mondo contadino dove la vita era grama e sofferta ma dove c’era un gran senso della vita comunitaria e della solidarietà. La “conquista” di oggi, su questo piano, è la solitudine; la breve felicità ha lasciato il posto alla lunga angoscia. È evidente che s’è spezzato un certo equilibrio. Dobbiamo riflettervi”.
“Io ho voluto raccontare la forza del popolo, la capacità di resistenza e di carattere dell’individuo, l’amore di sopravvive-re dell’uomo. Io dico: nonostante la miseria, crudeltà e dipendenza della loro vita, ciascuno di quei contadini del seco-lo scorso sapeva tener duro: noi, oggi, ne siamo capaci?”.
LA VERITA DELLA MEMORIA
Partiamo da qui, dal passato. Le “radici”. È in atto tutto un ampio fenomeno revivalistico di “ritorno alle origini” (dal salvataggio delle tradizioni, con i musei e le mostre d’arte popolare, alle manifestazioni più plateali e ipocrite, perché naturalmente sfruttate dal consumismo), spesso con caratteristiche più che sospette. Gli antenati sono di moda; ma è indubbio che al di là delle solite degenerazioni la ricerca di una cultura perduta ha una sua decisiva importanza. Come ha scritto Mario Guidotti, la tendenza comune, in Italia, è sempre stata quella di “non occuparsi del passato, addirittura a dimenticarlo, perché storia di profonde ingiustizie, di oscurantismo, di repressione”. Però ci si è accorti che le tradizioni sono sempre più ignorate e tutto un patrimonio etnologico, etnografico e folkloristico sta scomparendo, con l’effetto di gravi squilibri antropologici e psicologici. La conseguenza dell’innesto violento della cultura industriale in un paese antico come il nostro provoca un senso di sradicamento in tutti, la perdita di una precisa identità.
Il pericolo, che corre anche Olmi e che ha già corso Pasolini, è quello di mitizzare la scomparsa civiltà contadina.
Vera, non vera, quella situazione ambientale e sociale descritta da Olmi?
Realtà descritta com’era veramente, o realtà rivisitata nel segno idealizzante del ricordo o, addirittura, della nostalgia? Altri diranno (in questo stesso numero) della situazione storico-sociologica della plaga bergamasca alla fine del secolo scorso; è indubbio comunque che Olmi non ha inteso fare opera storica, da scienziato, nel far rivivere quella determinata realtà, quanto piuttosto ha compiuto una operazione semi-autobiografica, ricostruendo una realtà diversa dalla sua (e dalla nostra) basandosi sul patrimonio della memoria, con i vantaggi (il calore umano) e gli svantaggi (l’imprecisione) che ciò comporta. “Il mio è un film della memoria – l’impostazione è chiara – non vuole avere impegno né politico né sociologico”. E ancora: “Non mi sono valso di studi particolari. Mi sono affidato alla memoria”.
Certo, i pericoli sono in agguato, il discorso di Olmi sfiora il precipizio dell’estetismo, del pittoresco (dell’estetica degli stracci, insomma), ed è questo – insieme alla faccenda della mentalità bigotta, che poi vedremo – ad aver suscitato riserve in molti critici, o meglio ad averli messi in imbarazzo, tanto che molte recensioni apparse dopo la presentazione del film in pubblico definiscono L’albero degli zoccoli un gran bel film ma vi arrivano dopo una serie di “se” e di “ma”. Finiscono con la definizione di “capolavoro”, ma sembra che lo ammettano controvoglia.
È il caso, mi pare, di dichiarare forte e chiaro che il film si regge magistralmente in equilibrio sul filo teso del ricordo affettuoso di gente vissuta in un’epoca drammatica. Risolto liricamente: da qui derivano conseguenze del tutto accettabili e coerenti. Il modello di Olmi, se vogliamo, è Flaherty (specialmente quello di L’uomo di Aran), un regista che risolve appunto nel lirismo a caldo, nella partecipazione affettuosa, situazioni umane di drammatico rilievo. Non per niente Flaherty è l’autore di cinema che Olmi sente più vicino. Rossellini e il neorealismo direi che non c’entrano (il fatto che Olmi si avvalga di “attori presi dalla strada” riguarda un suo metodo abituale, un suo bisogno di sempre nell’ambito del suo cinema “artigianale”): la sua è una risposta poetica (ma sì), non una risposta pratica, posto che si possa stabilire queste definizioni come antinomiche.
Il ricordo, dunque, il racconto della nonna che rivive, un passato vicino ma sepolto sotto stratificazioni furiosamente accumulatesi, da riscoprire nell’illusione di conoscerci meglio; risalire alle radici per riscoprire i “valori” che contano; dunque perché l’operazione ci sia utile anche oggi.
Illusione, ho detto; ogni discorso fatto a parole su questo tema mostra la sua ambiguità e si tinge (se opponiamo la “sana”, “patriarcale” esistenza dei nostri vecchi con quella industrializzata, alienata, mercificata della nostra epoca) di reazionario. Nelle parole, Olmi non sfugge a questo pericolo; intendo dire che in molte sue dichiarazioni questa antinomia. passato positivo/presente negativo c’è sia pure sfumata in ragioni che appare così consolante accettare. Ma quando dalle parole passa ai fatti (al film), Olmi spazza via ogni ragione di perplessità e ci cattura, sentimentalmente e razionalmente.
Era cosi, non era cosi la vita dei contadini bergamaschi fine Ottocento? Sì e no, direi. Molti di noi che hanno ricordi della campagna possono indubbiamente aver avuto altre esperienze, e quindi proporre una diversa episodica, diversi atteggiamenti (ma pensiamo anche alla realtà geografica e ambientale: i contadini emiliani di Novecento di Bertolucci hanno reazioni più sanguigne, comportamenti più estrosi, ad esempio, dei contadini bergamaschi, decisamente più misurati, pacati e temperanti); tutto quello che c’è in L’albero degli zoccoli, però, trova riscontro in una verità precisa e documentata, anche se parziale.
La vita della cascina lombarda; i moduli del lavoro; il tipo di cibo (polenta e latte, un po’ di stracchino, carne solo nei giorni di festa, e quando si ammazza il maiale); le storie raccontate; di sera, alle famiglie riunite nella stalla, per usufruire del calore delle bestie; il camino come unica fonte i riscaldamento, di giorno (e la “monaca” nel letto, di notte); il parlare sottovoce, l’ossequio per il capofamiglia (e nella famiglia della vedova Runk capofamiglia è considerato il primogenito che lavora, anche se giovanissimo); l’uomo che decide, non senza aver cercato con gli occhi il consenso della donna; gli usi antichi (il rito della primavera, con i bambini che fanno fracasso per cacciare l’inverno); i detti popolari (“Quando la lüna la se incuruna, la nif la se muntuna” = Quando la luna ha la corona, la neve è in arrivo); il viaggio viaggio dei paesani a Milano considerato ” lungo e pieno di pericoli” (e sono venticinque, trenta chilometri), e così via.
 LA RASSEGNAZIONE E L’ATTESA NEL BUIO
LA RASSEGNAZIONE E L’ATTESA NEL BUIO
Colore locale? Atmosfera da presepe? Non direi. Un mondo visto con gli occhi di una memoria affettuosa, abbiamo detto, e dunque luoghi, fatti e personaggi restituiti in una luce che è quella dell’elegia (letteralmente: composizione in onore dei defunti, che non è necessariamente idilliaca; può essere anche dramma, sogno o delirio), con un implicito, irrazionale rimpianto; ma non nella luce della nostalgia. A livello razionale, Olmi sa bene quanto sudore e quante lagrime paga il contadino di fine Ottocento e quanto poco onesto sia ogni discorso sulla “fortuna” di vivere all’aria aperta, di essere a contatto con la natura, di nutrirsi di cibi sani e così via (l’ipocrita sospiro: ” Beati loro!”).
Noi spettatori siamo colpiti dalle “belle” immagini, dai “tipi” sbozzati con arguzia, dagli episodi saporosi e dai modi di dire vivaci, e rischiamo di non vedere tutto il resto, che è un di- scorso affilato e onesto sull’autentica condizione di vita di questi personaggi. Tutti bravi, tutti ossequiosi, tutti cuorcontenti? Che siano un po’ idealizzati è un fatto, ma c’è anche il Finard che mette le pietre nel carretto per alterare il peso del raccolto, il vecchio Brena incattivito quando ha bevuto, ancora il Finard che si “arrangia” col fattore e che litiga di brutto col figlio (con l’eccesso melodrammatico della “maledizione”), la ragazzina che quando capita l’occasione rubacchia la legna da ardere dalla catasta del vicino, e così via.
Ma ci sono soprattutto cose inequivocabili come la didascalia iniziale (“…La casa, le stalle, la terra, gli alberi, parte del bestiame e degli attrezzi appartenevano al padrone e a lui si dovevano due parti del raccolto”), la faccenda della cacciata del Batistì e di tutta la sua famiglia per un alberello tagliato, le dodicenni che vanno in filanda, le donne che per mantenere la figliolanza si ammazzano sui panni da lavare, i numerosi accenni alla fame e ai sacrifici (il pane bianco si dà solo ai malati e alle puerpere; le ciambelle con i grani di zucchero sono cose che si possono soltanto guardare nelle vetrine delle botteghe, le arance sono frutti rari, da mangiare nelle grandi occasioni perché arrivano da fuori, si devono comprare, mentre tutto quanto si consuma nella cascina viene prodotto nella cascina stessa)… Alcune cose si devono afferrare al volo, come appunto la faccenda dell’arancia, ellitticamente e delicatamente affidata al tono ammirativo di voce che ha Maddalena, in viaggio di nozze, quando tira fuori il frutto dal fagottino del pasto di mezzogiorno, e pronuncia una sola parola: “Ol portugal” (che vuoi dire appunto l’arancia).
La dimensione sociale, rifiutata come impostazione preliminare, alla lunga viene fuori ugualmente. Davvero è accettazione, la pazienza di questa gente che piega la testa sotto le in- giustizie, o non è piuttosto sopportazione?
Lo sguardo del Batistì al fattore che si porta via le bestie, poco prima della partenza dalla cascina, è di una eloquenza patente: nessuna ribellione, eppure non potrebbe essere più chiaro il senso dell’ingiustizia patita. Non c’è quel tipo di “happy-end” che è il grido di rivolta, la fiammeggianza di un preconizzato futuro che riscatti le iniquità, tipo “pueblo unido”; ma direi che il finale è eloquente a livello di costruzione razionale, mentre è carente proprio sotto il profilo emozionale. Pensiamo a come sono visti il ritiro delle bestie da parte del fattore e la partenza della famiglia del Batistì, un po’ oggettivamente e un po’ osservati attraverso le sbarre delle finestre cui si affacciano discretamente, senza intervenire per delicatezza, le altre famiglie, procedimento che sottolinea in modo prettamente cinematografico la sorte comune di quegli eventi, che non colpiscono soltanto uno di quei personaggi, ma tutti loro. Anche se la reazione degli altri è soltanto quella della preghiera, e poi della muta, corale partecipazione (quando il Batistì si è già allontanato, in modo che non sia in imbarazzo), tutti fuori sull’aia, nel buio, che è, senza sbandieramenti né inni di rivendicazione, una forma di attesa, una una aspirazione a qualcosa che cambi.
Per ora, quello che possono fare è dire il rosario “per chéla poera zet” (per quella povera gente). La religione dunque. I contadini di Olmi continuano a farsi segni di croce, a dire giaculatorie, a recitare preghiere, a frequentare la chiesa. Secondo la nostra ottica, sono dei codini, dei bigotti. Qualcuno ne trae la conclusione che codino e bigotto è Olmi. Che il regista bergamasco sia convinto cristiano è fuor di dubbio, ma che condivida i limiti dei suoi personaggi è una illazione gratuita. I suoi contadini nascono con questa formazione, respirano il bisogno del colloquio consolatorio con l’Aldilà, crescono con questo rapporto amoroso e timoroso con Dio: i contadini del secolo scorso di una “provincia bianca” come quella bergamasca così si comportavano. La religione è un riferimento terreno, tra l’altro, oltre che la rivalsa del poveretto, la sua speranza di risarcimento nell’Aldilà: il prete è autorità, consigliere, tramite, polo di riferimento, oltre che ministro della religione.
I preti del film, anche se visti simpaticamente, restano preti del loro tempo. Il curato del paese, nel mettere in guardia i novelli sposi dai “pericoli” del viaggio a Milano, li avverte che “incö la zet la gh’a di idee balurde” (oggi la gente ha delle idee balorde), e il prete presente sul barcone esclama, supponendo che il fumo nero osservato sulla riva derivi da uno scontro tra soldati e dimostranti: “Non c’è più religione né rispetto per il prossimo” (riferendosi presumibilmente al “disordine” causato dai dimostranti).
RELIGIONE/LEGAME, RELIGIONE/INVESTIMENTO, RELIGIONE/SUPERSTIZIONE
Un filo di ironia accompagna tra l’altro questi personaggi di religiosi, che capitano sempre all’ora giusta, al momento di mangiare o quanto meno a mettere un’ipoteca su quel momento (il curato all’uccisione del porcello: “Béla bestia, ghe n’è de roba!” = Bella bestia, ce n’è di roba). Ma il concetto che ha il parroco della religione vissuta è piuttosto illuminato e “pratico”. Alla vedova Runk che lava i panni e si dispiace di non poter andare a messa obietta che è più importante aver cura dei figlioli che andare in chiesa; durante la predica della sagra del paese dice che “l’amor di Dio noi possiamo meritarcelo solamente con l’amore del prossimo” e riporta il miracolo della Madonna delle lacrime ai miracoli che tutti i giorni accadono nella natura; al matrimonio di Maddalena e Stefano, incitando i due sposi a volersi bene, precisa che “il Paradiso comincia dall’amore che noi ci vogliamo qui sulla Terra”.
Ma questa religione è anche superstizione, nei gesti, nelle formule, nei segni di croce reiterati. Tanto spesso ripetuti questi segni e queste preghiere servono a tener lontane le disgrazie, sono delle polizze assicurative contro guai, malattie, avversità. Dire bene il Pater per far scappare i diavoli, insegna nonno Anselmo ai nipotini, ma anche i grandi coltivano la dimensione di un fantastico empio (il buio, le anime dannate, il diavolo in agguato) che si può esorcizzare col segno di croce. È un fatto che, come nel film, l’immagine di Sant’Antonio, protettore degli animali, era infisso sulle porte delle stalle in funzione di salvaguardia (e quando le bestie erano ammalate, l’immagine veniva spesso posata sulla loro testa). A volte religione e superstizione, come in tante civiltà anche lontanissime fra loro, si sovrappongono: la “donna dei segni” chiamata a guarire il Finard fa trangugiare al paziente il bicchiere d’acqua in cui sono immersi i pezzetti di spago ma gli fa anche recitare delle giaculatorie.
C’è il senso proprio del divino, del celeste (la meraviglia del miracolo, di cui restano i segni esteriori, l’elmo e la spada dell’incredulo ufficiale francese), ma c’è soprattutto il senso imminente della fede “utile” e del legame che unisce l’uomo al cielo, cosi come alla terra. Il “miracolo” della mucca che guarisce perché la vedova le fa bere l’acqua benedetta non ha altro senso.
La donna crede nel rapporto causa-effetto, si sente solidale con gli altri che hanno bisogno di lei, sa di non meritarsi una batosta come la morte della bestia, “ha diritto” al miracolo (che poi invece sia circostanza fortunata non ha importanza): “Fatemi la grazia, Voi conoscete la mia situazione, non potete rifiutarmela”. Religione in senso proprio vuoi dire legame, stare assieme, e questi contadini sanno cosa vuoi dire, stanno insieme fra loro e insieme con la natura, in una sorta di inconscia armonia (che noi ora idealizziamo o ci ironizziamo sopra, atteggiamenti ambedue sbagliati) tra uomo, stagioni e Cielo.
Panteismo? Inutile sottilizzare: sta di fatto che animali e cristiani sono visti accumunati da un’unica sorte (quando dormono nella notte in cui cade la prima neve), e che la preghiera è una forma di partecipazione, cosi come la solidarietà. “Se non ci aiutiamo fra noi!” – dice proprio la vedova Runk alla Batistina che ha appena assistito per il parto, e la suora di Milano affida il bambino abbandonato ai due coniugi sposando la carità alla convenienza (la “dote” del bambino).
La carità, appunto, che in quest’ottica dà sempre i suoi frutti. Non per niente, mentre la vedova prega alla cappella, i suoi danno da mangiare allo scemo del paese: la carità è Carità. Far bene sulla Terra “rende”, prima durante la vita e poi in Cielo; ma non basta evitare di compiere il male, per maritarsi il Paradiso, occorre anche aiutare il prossimo, cosi il cerchio si chiude (al vecchio Finard che si vanta di meritare il Paradiso perché non ha ammazzato nessuno, il parroco risponde: “L’è mia asé, l’è mia asé!”, ossia ” Non basta”).
E poi, insomma, questa era la realtà del tempo, il costume usuale. Rimproverare ad Olmi che manca nel suo racconto la dimensione politica, che i suoi contadini subiscono isolatamente e non si aggregano, non hanno stimoli associativi e di rivolta, significa forzare la mano alla realtà dei fatti e alle sue intenzioni. L’albero degli zoccoli è un romanzo, un affresco, ma non può e non vuole tener conto di tutti gli aspetti del mondo evocato; è basato su un “taglio” particolare, una scelta, ed è per questo che va giudicato.
È comunque eloquente, ai fini del discorso “politico”, l’episodio dell’oratore socialista alle cui alate parole corrisponde l’ottusità assolutamente personalistica degli ascoltatori, esemplificata dal ritrovamento del marengo d’oro da parte dell’avido Finard, il quale, proprio alle parole: ” È cosi che la società comincia ad animarsi, le scienze, le arti, le industrie e anche il costume politico si trasformano…” non sa trattenere un sonoro sogghigno mentre rinchiude nel pugno il marengo, prima di allontanarsi per celarlo alla vista di tutti. All’utopica “opera generosa e disinteressata” degli uomini illuminati corrisponde insomma l’interesse più gretto e più individualistico.
l contadini di quel tempo non sanno niente di classe, non hanno coscienza sociale, non concepiscono il fronte comune contro le prepotenze, ed anche questa è una definizione storica della loro miseria.
MINEK È OLMI, NOI SIAMO MINEK
Allora, lasciando stare i bizantinismi dei riferimenti colti (Vir-gilio e Manzoni, De Marchi e Pratesi, Segantini e Millet: ma io personalmente tirerei semmai in ballo Tolstoj o, più modestamente, Fogazzaro, Tomizza e Camon), consideriamo L’albero degli zoccoli per quel che è, un bel racconto col sapore della genuinità, semplice e vivace, su un mondo che non è più, quel mondo contadino che il cinema italiano cosi rare volte ha visitato (praticamente mai, se si eccettuano il citato Novecento e Gli ultimi, di Vito Pandolfi e Davide Maria Tu- roldo). Un racconto quasi sempre felice, pieno di cose, e non soltanto di cose piacevoli.
Sbarazzerei il campo di un possibile equivoco: questo mondo di semplici non è visto da un semplice. In L’albero degli zoccoli non c’è niente di ” naif”, anzi: è un film calibratissimo nella sua struttura, studiatissimo nei rapporti delle sue parti ad incastro, molto elaborato nella “semplicità” dei dialoghi. Un’opera raffinata, piena di dettagli significanti, in un accumularsi di episodi che si compongono in un “corale” (in senso proprio, cioè musicale).
Basta vedere come il regista lega fra loro, con morbida “souplesse”, i vari momenti e i vari personaggi. Per esempio: il bambino che va a scuola, con la cinepresa che nel seguirlo si ferma sul carro col grano in partenza per il mulino, sul quale sta Pepino, il figlio maggiore della vedova Runk, e poi “incrocia” nonno Anselmo che va nel pollaio a raccogliere il letame delle galline. O la riunione nella stalla, di sera, con il Batistì che racconta le storie e il pretendente di Maddalena che arriva con gli amici (“Gh’è ché i lömagocc” = Son qui i lumaconi, commenta la Batistina), il suono delle zampogne che chiama tutti fuori, col naso all’aria perché il cielo promette neve, il ritorno a casa di Stefano, la sua sosta nel cortile del padrone, il bellissimo e un po’ misterioso episodio del padrone che sogguarda dall’esterno il figlio che suona il piano (anche lui, uomo rozzo, è un escluso rispetto alla salottiera “civiltà” della moglie e del figlio), la prima neve che cade nella notte, gli animali che riposano, i contadini che dormono, il cane che uggiola e che sveglia nonno Anselmo il quale si alza per mettere il letame di gallina sulla terra, per tenerla calda sotto la neve. O la nascita dell’ultimo figlio del Batistì, ancora ritmata dal figlio maggiore che va a scuola, incrociato dalla bambina che va a chiamare il contadino nei campi, il quale arriva in cascina osservato dal Finard (sta controllando il marengo nascosto nello zoccolo del cavallo) e dal nostro occhio di testimoni, che passando davanti alla finestra della vedova Runk si sofferma a vedere nonno Anselmo il quale racconta storie ai nipoti.
Tutti esempi di una fluidità che definirei proprio musicale. La musica di Bach, nella colonna sonora, mi pare invece superflua. Olmi stesso ha detto che “il film rifiutava qualsiasi tipo di musica”, ma poi si è risolto per gli interventi all’organo di Fernando Germani (soprattutto il Corale dalla Cantata 147, l’Adagio dalla Cantata 156, la Fuga in sol), spiegando che in certo senso ” fu la musica a scegliere il film”. È solo un gioco di parole: a mio giudizio questo tipo di musica è pleonastico, se non dannoso per la sua esplicita, troppo dichiarata intenzione di “legare” la terragna esistenza dei contadini al significato sacrale di un’esistenza dove anche il lavoro è religione (in un’altra ottica, ma sostanzialmente agli stessi fini, anche il Pasolini di Accattone aveva usato Bach). E poi L ‘albero degli zoccoli è pieno di bellissime citazioni di canzoni popolari, filastrocche, musica da fiera, ecc. e di una presenza eloquente, il suono delle campane: non c’è bisogno d’altro, non occorrono sforzi di nobilitazione.
Il tocco di accademismo, insomma, c’è. Anche nel coretto delle suorine di Milano, a proposito di colonna sonora, che lega insieme i tempi diversi del soggiorno in convento dei due sposi e sa tanto di idillio. Ma, a parte il sapiente uso della luce (un conto gli interni, un conto gli esterni) e il tono eccellente della fotografia, di cui è responsabile diretto lo stesso Olmi; a parte la vivacità descrittiva (tutta la sequenza del matrimonio e poi il lungo “corpus” del viaggio di nozze, dove il ritmo convulso dell’imbarco si placa nella distesa descrizione del viaggio per acqua, lunga pagina sostenuta efficacemente, qui, dal timbro raccolto del violoncello) a parte tutto questo, dicevo, quel che caratterizza il film l’ho trovato nel fatto che tutto sembra visto dalla parte dei bambini, ossia dei posteri.
Vedi il rapporto tenerissimo fra nonno Anselmo e la nipote che lo segue nelle diverse fasi dell’avventura dei pomodori; le favole che il nonno racconta ai piccoli; le figlie della lavandaia che fanno oggetto di gioco la fatica di trasportare i panni in carriola (con osservazioni finissime sulla psicologia del bambino povero: il figlioletto della vedova Runk è corso a chiamare il veterinario e, pur nel momento doloroso, non può nascondere la sua contentezza per aver fatto il tragitto in calesse); i bambini che ascoltano a bocca aperta le storie nella stalla, che si incantano alle meraviglie del Frikì, il merciaio ambulante, che guardano tutto, osservano in silenzio, fanno domande, si parlano all’orecchio, sono continuamente presenti. Li rappresenta tutti Minek, il bambino che va a scuola, tranquillo e modesto quanto gli altri sono allarmati per la “novità” (“Ü s-cet de paisà chel và a scöla! I diserai cosé?” = Il figlio di un contadino che va a scuola! Cosa dirà la gente?), legato al suo ruolo di “uomo nuovo” anche nei momenti drammatici. Dopo che la sua presenza di scolaro ha siglato la vita della cascina, lo vediamo significativamente fare il compito la sera stessa della cacciata della sua famiglia, e lo vediamo salire sul carro con la sua cartella di pezza. L’ultima presenza umana del film, prima della partecipazione silenziosa del “coro” e del lumino che i si allontana nella notte, è lui, Minek. Sul carro, la madre guarda il neonato poi Minek, e quest’ultimo ricambia lo sguardo prima di osservare per un’ultima volta la cascina: è lui a farsi tramite fra il passato e il futuro, fra il mondo dei suoi genitori e quello che appartiene a lui e al fratello ultimo nato. Il racconto è come se fosse visto attraverso gli occhi di Minek. Ermanno Olmi si sente quel ragazzo, anche se anagraficamente potrebbe essergli nipote o pronipote.
Per quanta simpatia possiamo nutrire (chi di noi si sente a sua volta rampollo di questo Minek) per il mondo contadino del passato, il film non ci induce a coltivare la nostalgia. Né, seguendo contestazioni ideologiche culminate negli attacchi ferocissimi di Camon e di Moravia a postulare un ritorno all’antico e a “sostenere una morale che non serva ad altro che a perpetuare lo stato di miseria e di sofferenza” descritta. Io credo che Olmi salvi semmai lo spirito con cui quella gente subiva quello che subiva, constatando che non sapeva fare altro, non per questo giustificando od esaltando quelle condizioni di vita.
Il film di Olmi è da leggere bene perché è più sottile di quel che sembra, legato com’è all’ellissi e alle sfumature: è il solito discorso relativo alle sue fatiche, facili in apparenza, complesse nella sostanza. L’ideologia può essere discutibile, ma, come già accennato, soprattutto sul piano delle più o meno solenni dichiarazioni di fede. L’oggetto film invece, come il viaggio a Milano dei due sposi, è “lungo e pieno di pericoli” ma, come quelli si portano a casa il marmocchio, risolve il viaggio dello spettatore con una acquisizione concreta, una meditazione che sta a noi compiere correttamente sull’ieri e sull’oggi, sui padri e sui figli e soprattutto sull’ineluttabile trasformazione che purtroppo, fortunatamente (direbbero Leo e Perla), ha subito la civiltà contadina.
di Ermanno Comuzio «L’albero degli zoccoli di Ermanno Olmi» su Cineforum n° 179, novembre 1978